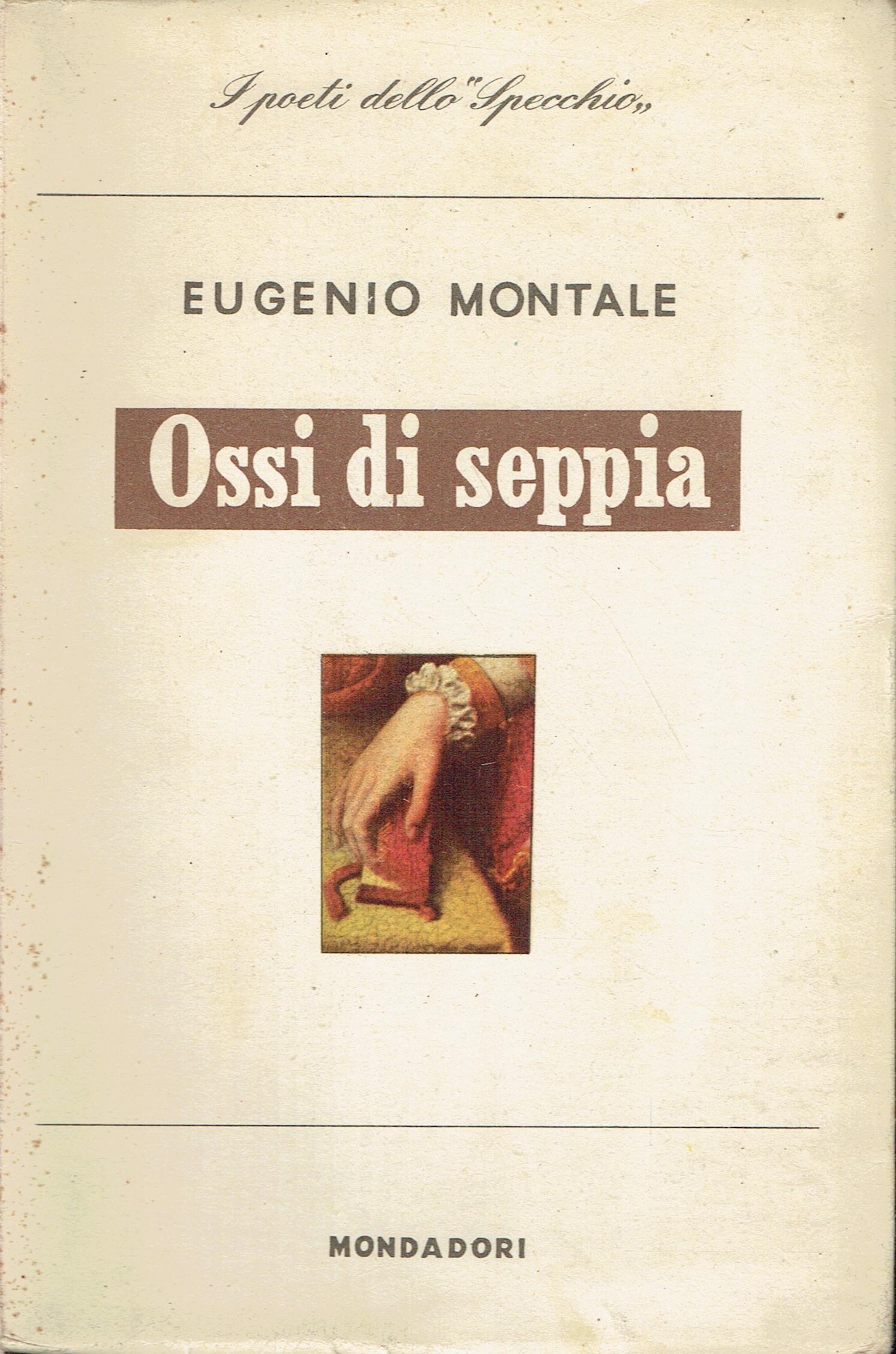era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato». È questa una delle più famose liriche di Eugenio Montale (1896 – 1981), tratta dalla sua prima raccolta, Ossi di seppia, del 1925. Il titolo della raccolta «è una metafora della condizione esistenziale ridotta a nudo e privata di tutti i suoi illusori abbellimenti» (Anna Mattei). In essa il paesaggio ligure, il mare, i limoni, i sonnolenti pomeriggi d’estate fanno da sfondo alla meditazione del poeta sull’insensatezza della vita e sulla sua disillusa volontà di trovare una chiave dell’esistere. La poesia, composta da due quartine rimate di endecasillabi salvo l’ultimo verso che è un doppio settenario, ha un linguaggio piano, conciso, ed è già un esempio di quella tecnica che viene definita del “correlativo oggettivo”, dove i concetti e i sentimenti sono affidati alle figure sensibili, agli oggetti appunto. Ma che cos’è il male di vivere? È l’angoscia che prova l’uomo di fronte al nulla che minaccia l’esistenza, di fronte alla caducità e all’insignificanza delle cose, paragonate ora al corso d’acqua che non fluisce tranquillamente, ora alla foglia che si arrotola su di sé, ora al cavallo che stramazza al suolo. L’unico bene che ci resta – suggerisce il poeta – è affidarsi alla «divina Indifferenza» del mondo, a quel distacco dalle passioni di cui parlavano gli Stoici, e questo bene viene raffigurato, per contrasto con le immagini precedenti, con l’immobilità della statua e con la leggerezza della nuvola e del falco. Il tema del “male di vivere” percorre tutta l’opera di Montale. La divina indifferenza del mondo, di quel mondo la cui essenza il poeta cerca invano di cogliere, è come il Dio lontano di cui parla il filosofo Sossio Giametta, che coincide con l’amoralità e l’onnipotenza della Natura e che in qualche modo richiama filosoficamente l’infinita sostanza, il Deus sive natura di Spinoza. La poesia di Montale nasce, infatti, da una tensione filosofica. I suoi punti di riferimento sono certamente Leopardi e Schopenhauer, ma la sua sensibilità poetica anticipa potentemente quelle tematiche come l’angoscia, lo scacco, l’assurdo, la nausea, che proprio in quegli anni saranno oggetto della riflessione filosofica, da Essere e tempo (1927) di Heidegger alla Filosofia dell’esistenza (1938) di Jaspers, dal Mito di Sisifo (1943) di Camus a L’essere e nulla (1943) di Sartre. Nonostante la dichiarazione di Montale (che citava Verlaine) di voler torcere il collo all’eloquenza, sul piano formale egli deve molto a D’Annunzio, cui lo accomuna il lessico ricercato, la metrica accurata, i termini letterari e aulici, la preziosità delle figure retoriche. Quello che invece lo allontana dal poeta dell’Alcyone è la sua visione del mondo: al sentimento panico della Natura, all’adesione piena e sensuale alla vita di D’Annunzio, Montale contrappone una visione pessimista, la coscienza del dramma esistenziale dell’uomo impossibilitato a cogliere l’essenza della vita: «Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d’intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità. Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.» (da I limoni) Ossi di seppia si distingue in genere per l’essenzialità e l’aulica discorsività del linguaggio dalle successive raccolte, ci riferiamo in particolare a Le occasioni del 1939 e a La bufera e altro del 1956, forse sopravvalutate da una parte della critica, mentre, a nostro avviso, per il linguaggio artificioso, contorto, ellittico segnano un’involuzione stilistica e sembrano fare quasi il verso al contemporaneo ermetismo (senza però la musicalità di un Quasimodo o le coloriture semantiche e surreali di un Bodini). In queste raccolte dominano infatti una sintassi e un lessico complessi, non di rado oscuri, che tolgono lucentezza e forza alla poesia. Ovviamente non mancano alcune magnifiche eccezioni come La casa dei doganieri. Ma non a caso: un critico come Pier Vincenzo Mengaldo, parlando di questa composizione, nota come «sia ancora così legata, anche formalmente, al mondo degli Ossi»: «Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t’attende dalla sera
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri
e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura
e il suono del tuo riso non è più lieto:
la bussola va impazzita all’avventura
e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi; altro tempo frastorna
la tua memoria; un filo s’addipana. Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana
la casa e in cima al tetto la banderuola
affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo; ma tu resti sola
nè qui respiri nell’oscurità. Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende
rara la luce della petroliera!
Il varco è qui? (ripullula il frangente
ancora sulla balza che scoscende…).
Tu non ricordi la casa di questa
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.» Montale resta il grande poeta dei «fili interrotti» (Umberto Fiori), del disorientamento dell’esserci, dello scacco della ragione.